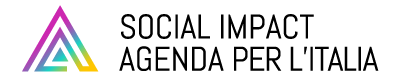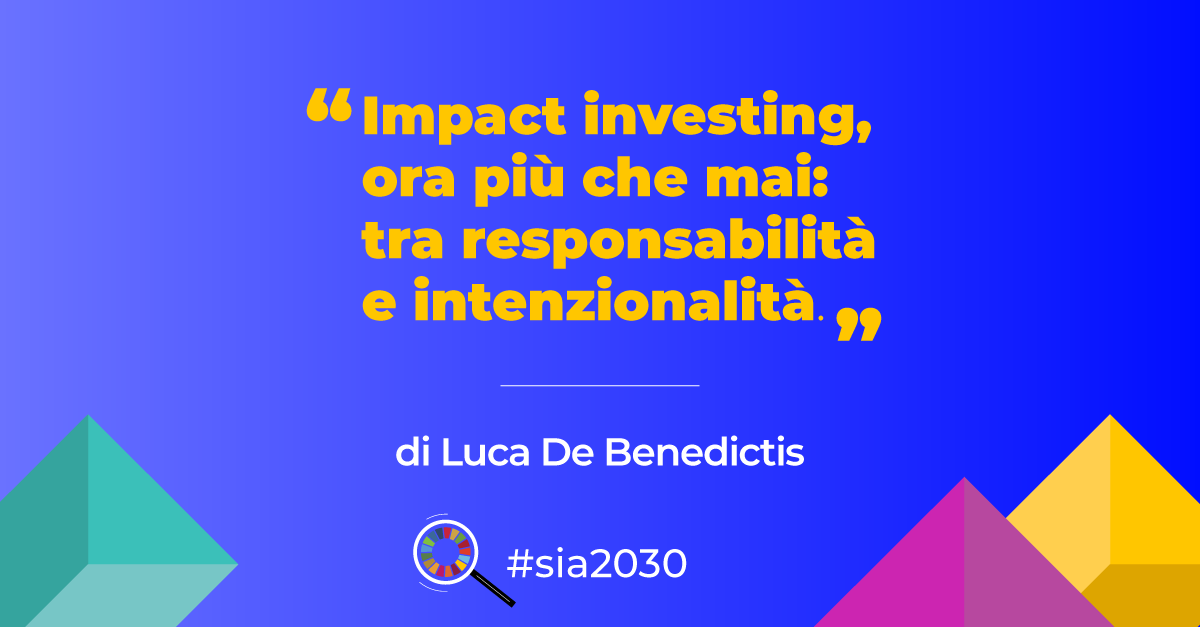
di Luca De Benedictis, responsabile Finanza sociale e Reporting, AICCON
“Ha senso, in un’epoca in cui BRICS e USA retrocedono sulle politiche ESG, continuare a investire in impatto?”, qualcuno mi ha chiesto in chiusura di un mio recente intervento su temi di finanza sociale rivolto a investitori a impatto e professionisti del settore. Erano i giorni dell’insediamento della presidenza Trump e dei primi provvedimenti esecutivi volti a ridimensionare la rilevanza delle politiche ESG-oriented. La mia risposta, di getto: “più di prima”. A distanza di giorni ne sono ancora più convinto e provo qui a spiegare perché.
Sfide G-locali e impact investing
Le sfide del nostro tempo sono interconnesse, lo rileva anche il World Economic Forum¹ che individua le disuguaglianze quale principale fattore di rischio del prossimo futuro delle nostre società, evidenziandone i legami con questioni afferenti ad aree “semantiche” molto diverse, quali la disinformazione, ad esempio, e il rallentamento economico. Inoltre, è sempre più evidente come le sfide dell’oggi, pur avendo natura (ed origine) globale, mostrino i propri effetti a livello locale, incidendo in maniera distinta a seconda dei contesti: l’esempio più semplice è quello legato alle catastrofi naturali che hanno una natura globale ma che mostrano effetti localizzati, incidendo su economie e dinamiche sociali di territorio.
Di fronte alla complessità di questo scenario, già nel 2021 lo European Sustainable Investment Forum, metteva in luce come la significativa crescita degli investimenti sostenibili non si fosse tradotta in miglioramenti concreti per l’ambiente e la società².
L’approccio ESG, infatti, pur rilevante, risulta limitato nella misura in cui propone una visione orientata alla performance (finanche sociale ed ambientale), e non ragiona delle cause ma piuttosto delle correzioni a valle di processi di produzione del valore che non vengono però messi in discussione, pur essendo causa di quelle distorsioni. In altre parole, rappresenta un semplice tassello in un mosaico più ampio e necessario per costruire un modello di sviluppo autenticamente orientato a una maggiore giustizia socio-ambientale.
Impresa, Ambiente, Società: una nuova generazione di soggetti economici
Negli ultimi anni, il concetto di ESG e di responsabilità socio-ambientale d’impresa hanno acquisito rilevanza nel dibattito politico ed economico. Le recenti policy in materia sono però il risultato del recepimento di un percorso di lotte che dagli anni ‘70 hanno puntato i riflettori sulla necessità di una impresa che, dopo un’epoca di anti-socialità (prima industrializzazione – l’impresa ha interessi opposti a quelli della società) e una di a-socialità (post seconda guerra mondiale – impresa e sociale sono sfere separate) ha avuto il merito di traghettarci verso una generazione di imprenditori sociali – nell’accezione anglosassone – che ha dato vita a modelli di impresa che pongono la questione socio-ambientale tra i fattori di attenzione del proprio agire.
Gli stessi SASB – Sustainability Accounting Standards Board e GRI – Global Reporting Initiative sono il risultato di
un’azione collettiva, e non di un’impostazione normativa, come dimostra anche il fatto che il lavoro dell’EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group sia ripartito proprio da lì per definire gli ESRS – European Sustainability Reporting Standards.
Siamo però alla vigilia di una quarta fase, quella dell’impresa intenzionalmente sociale³ per cui, all’interno dell’universo indistinto di soggetti (profit, non profit, finanziari, ecc.) che di socio-ambientale si occupano, sempre più – e qui veniamo al tema – è rilevante distinguere tra quelli che fanno della materia socio-ambientale uno strumento di de-risking (minimizzazione del rischio) e quelli per cui la sostenibilità non è un mezzo (ulteriore) per alimentare schemi di profitto, ma piuttosto l’orizzonte comune verso cui orientare la propria azione.
Impatto, per compliance o per missione?
Sono i criteri IMA⁴ a restituirci come il livello di integrazione della dimensione impatto all’interno di un modello di business sia il risultato del combinato disposto di tre elementi: la capacità di mettere in campo azioni non semplicemente adattive ma trasformative⁵ (addizionalità), in grado di influenzare cambiamenti misurabili (misurabilità) e che siano la conseguenza di un’azione intenzionale (intenzionalità). Prima ancora di discutere di quanto e cosa sia misurabile (su questo si rimanda al dibattito ormai decennale sul tema della misurazione dell’impatto) è necessario allora interrogarci, e restituire valore e rilevanza alla, troppo spesso dimenticata, intenzionalità.
La rapidità della massificazione dei concetti di ESG e sostenibilità e la concomitanza con una progressiva normalizzazione dell’adozione di pratiche di valutazione dell’impatto hanno generato un misunderstanding di base che, nella semplificazione, ha portato ad assimilare sempre più le due sfere concettuali, finendo per assumere che occuparsi di responsabilità socio-ambientale sia sufficiente per promuovere un cambiamento⁶.
Nulla di più sbagliato. Gli ESG sono uno schema concettuale, le cui metriche (anche a ragion veduta dopo le varie pubblicazioni dell’EFRAG) ragionano di capacità performativa (finanche socio-ambientale), ma non dicono nulla delle intenzioni dei soggetti, alimentando l’incapacità di distinguere tra azioni riparatorie e azioni trasformative. Che senso ha investire in benessere del personale se il mio modello d’impresa spinge lavoratori e lavoratrici al limite delle proprie capacità psicofisiche? Che senso ha finanziare progetti ‘sociali’ se la mia impresa genera strutturalmente danni socio-ambientali attraverso lo sviluppo della propria attività principale (core business)? Che senso ha finanziare cooperazione in contesti di emergenza sanitaria se contribuisco al mercato degli armamenti?
L’impianto ESG, come proposto da normativa, può essere un innesco rilevante per una strategia integrata, ma pur sempre di performance. Per affrontare le sfide del nostro tempo è invece necessario promuovere modelli d’impresa intenzionalmente sociali (e non solo socio-ambientalmente responsabili), che mettano l’interesse di persone ed ambiente a monte delle scelte.
Investire in impatto
Con il termine “finanza sostenibile” si tende a riferirsi di fatto a una eterogeneità di pratiche che vanno dall’investimento in DNSH (do not significantly harm), ovvero in organizzazioni e progetti che rendicontano di non generare significative esternalità socio-ambientali negative, sino ad arrivare al vero e proprio investimento in impatto, procedendo su un continuum di senso che unisce tali polarità. Investire in impatto infatti è sostanzialmente diverso, perché significa preferire, premiare e supportare modelli organizzativi non solo e non tanto responsabili (pur fondamentale), ma intenzionalmente orientati a contribuire a una visione di mondo in cui sviluppo d’impresa, cura dell’ambiente e centralità del benessere umano siano al contempo obiettivi dell’agire. Quando l’orientamento è all’impatto, la dimensione finanziaria è un fattore produttivo in cui la funzione obiettivo è l’interesse della collettività.
Tornando alla domanda da cui sono partito: “Ha senso, in un’epoca in cui BRICS e USA retrocedono sulle politiche ESG, continuare ad investire in impatto?”, la risposta è, ancora una volta “ora più che mai”: tanto più viene meno la spinta politica dell’investimento responsabile, tanto più è indispensabile investire in impatto.
Ora più che mai è necessario andare a monte dei modelli di business e dotarsi di strumenti per riconoscere e premiare quelli che contengono nel proprio DNA gli anticorpi in grado di screditare l’ipotesi che serva, in un secondo momento, a valle, un’azione correttiva; in altre parole, si rende sempre di più necessario preferire imprese intenzionalmente sociali e non solo a responsabilità sociale. In questo la scelta allocativa di risorse ha un ruolo decisivo, anche nell’indirizzare le future politiche.
La Third Way europea: economia sociale e imprese a impatto
Gli USA hanno dichiarato il loro arretramento in materia di responsabilità socio-ambientale in occasione della missione all’ONU del 7 Marzo 2025 ma, a ben pensarci, le big quali BlackRock e Meta, si sono ritirate dalla Net Zero Asset Managers Initiative ancora prima che l’amministrazione Trump prendesse posizione pubblicamente. Ciò dice molto del livello di intenzionalità delle decisioni prese precedentemente da questi soggetti e, osservata da più vicino, nasconde anche la filosofia economico-culturale che sottostà a questo tipo di decisione. Non è stata la decisione politica a convincere BlackRock e Meta a sottrarsi dai loro impegni, ma l’opportunità di farlo: Net Zero rappresenta un vincolo, e quindi un costo finanziario, che adesso ho l’opportunità di non assumere. Deal.
Da settimane si dibatte su quale ruolo interpreterà l’Europa in questo rinnovato quadro di politica internazionale, rilevando un sostanziale immobilismo dei decisori politici ben interpretato dal ‘do something’ (nuovo “whatever it takes”) che, lo scorso 18 febbraio, Mario Draghi ha rivolto al Parlamento europeo. Forse è l’occasione per costruire davvero una third way che valorizzi e riparta dall’identità e dal substrato socio-economico e culturale europeo e daii principi su cui l’Unione europea è stata costituita. Più di qualsiasi altra cosa, il tessuto imprenditoriale europeo si distingue dagli altri per la presenza di economia sociale, ovvero quel comparto di organizzazioni che, a vario titolo subordina il profitto all’interesse collettivo. Il settore conta ad oggi 4,3mln di imprese (1 su 10 è in Italia – 9,4%), impiega 11,5mln di persone (13,3% in Italia) e genera valore aggiunto per 912 miliardi di euro (14,1% in Italia). Opera in tutti i settori chiave per lo sviluppo territoriale, dall’agrifood, all’edilizia, all’educazione e finanche i servizi finanziari.
Nel 2021 la Commissione Europea riconosce l’Economia Sociale quale uno dei 14 ecosistemi industriali dell’Unione⁸ e con il Social Economy Action Plan 9 sottolinea l’importanza di fare leva su di esso per immaginare e rendere possibile l’Europa di domani, oltre a proporre azioni concrete per lo sviluppo del settore.
Se investire in impatto è sostenere una visione di mondo e di sviluppo, è questo il momento di restituire senso a questo impegno.
______________________________________________________________________________________________________
1 The global risks report 2025. Insight Report. World Economic Forum (2025).
2 Eurosif Report 2021. Fostering investor impact. Placing it at the heart of sustainable finance. Eurosif. 2021.3 Per approfondimenti sul tema dell’intenzionalità, si faccia riferimento a:
– Venturi P. Il valore istituente dell’impatto sociale e il secondo tempo dell’Impact Investing. Social Impact Agenda. 2024
– Venturi P. Intelligenza artificiale guidata dall’intenzionalità sociale. Sole24Ore. 17 Febbraio 2025.
4 Tiresia Social Impact Outlook. Tiresia (2019).
5 Ovvero in grado di cambiare gli assetti sociopolitici ed istituzionali, il nostro modo di stare insieme. Per approfondimenti si rimanda a La prospettiva civile dell’impatto sociale. De Benedictis L., Miccolis S., Venturi. P., Zamagni S.2023.
6 Si rimanda qui al sopracitato documento pubblicato da Eurosif nel 2021 – nota 2.7 Benchmarking the socio-economic performance of the EU Social Economy. European Commission. 2024.
8 Annual single market report 2021.Updating the 2020 new industrial strategy: building a stronger single
market for Europe’s recovery. European Commission. 2021.
9 Building an Economy that works for people: an action plan for social economy. European Union. 2021.
Luca De Benedictis
Ha lavorato come consulente per imprese sociali in Alterna – Center for Social innovation and Entrepreneurship, come agente di prestito (microfinanza) per cooperative ed imprese recuperate per The Working World e condotto studi d’impatto, tra cui un’analisi dei benefici generati dal sistema di commercio Fairtrade per le comunità e le economie locali in Colombia e Repubblica Dominicana. Oggi ricercatore in AICCON, responsabile dell’area Finanza Sociale e e Reporting, continua a coltivare il suo interesse per il mondo cooperativo e dell’economia sociale svolgendo attività di ricerca e formazione.